IL GIOCO TRADIZIONALE
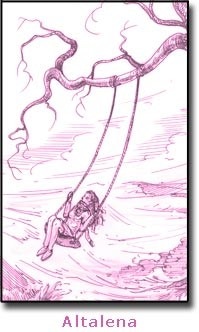
Un dato certo è quello che molti giochi sono praticati, in modo simile, in molte regioni della terra tra i popoli civili e quelli barbari e questo è un fatto straordinario.
Osserva il Pitré “Questo fatto ha un grande significato per l’etnografia e porta un certo contributo nelle spiegazioni di alcuni fenomeni psicologici e sociali. Ci sono degli svaghi come quello dell’anello o del cerchio o della palla o della trottola o della moscacieca che si riscontrano sia fra i popoli dell’Europa che tra i negri dell’Africa, sia fra gli indigeni dell’America che nelle tribù selvagge dell’Oceania. Ciò dimostra che vari giochi hanno un fondo comune di tradizione, cioè uno l’ha imparato dall’altro, in epoche quando gli uomini delle primitive sedi dell’umanità si portarono nelle diverse contrade, modificandoli e adattandoli ai nuovi ambienti e alle nuove abitudini.” Il grande folclorista siciliano afferma che almeno un terzo di giochi conosciuti in Italia nell’Ottocento era patrimonio dei fanciulli e degli adulti di gran parte dell’Europa. In questo lavoro vengono riportati, in alcuni casi, nomi di giochi simili praticati in varie regioni italiane, non sempre, però, questi giochi sono perfettamente uguali, anzi spesso ci sono differenze nei regolamenti e nello stesso modo di giocare. Questo è il segno evidente della grande originalità e creatività che sta alla base dei giochi ma, che non esclude l’evidente collegamento tra le svariate espressioni. La maggior parte dei giochi di ieri si svolgevano all’aria aperta, erano passatempi semplici, salutari e più adatti alla vita di allora. Le case erano molto piccole e poco comode, mentre di spazi liberi se ne trovavano in abbondanza, la piazza diveniva un ottimo laboratorio. I momenti di tempo libero da dedicare al gioco erano veramente pochi ma, quando questo accadeva, giocavano tutti, grandi e piccini, e non mancavano gli spettatori che assistevano alle prove. I giochi erano basati sulla destrezza, sull’agilità, sulla velocità, sulla coordinazione ma principalmente sulla forza fisica. A volte diventavano violenti ed aggressivi perché, in parte, rispecchiavano i comportamenti sociali del tempo. I giochi, sono sempre figli del tempo e si adattano al contesto sociale nel quale si svolgono. Ieri non esisteva nessun disturbo dall’esterno, niente TV, niente computer, scarsissima produzione industriale di giocattoli con, in compenso, una solida presenza di rapporti interpersonali e di socializzazione. Era considerato importante lo stare insieme, anche i momenti di lavoro si trasformavano in occasione di socializzazione. La persona allora era al centro della società e il gioco era di tipo collettivo-creativo e ad alto contenuto sociale. I bambini di oggi non sanno più cosa voglia dire avere un cielo azzurro sulla testa, schiacciati dalla loro passività di soggetti cresciuti davanti alla TV, con gli occhi abituati ad incamerare sempre più immagini e a produrre sempre meno parole. Ieri il bambino non aveva bisogno dell’adulto, della guida, erano indipendenti ed autonomi nel gioco prima e nella vita, poi; oggi non sono abituati a scegliere, c’è sempre qualcuno che provvede ad indirizzarli verso qualcosa e quando non c’è l’adulto c’è bisogno del computer o di altro. L’oggetto giocattolo è il nulla e dietro di esso si aggrovigliano il vuoto delle relazioni umane e l’assenza della fantasia, della creatività e dell’inventiva; in questo modo il gioco, inteso come tempo della piena libertà infantile, viene spogliato di spazi ampi e differenziati e mutilato dei propri segni educativi quali il movimento, la comunicazione, la fantasia, l’avventura, la costruzione, la socializzazione. Il bambino, spesso, non sceglie in base alle sue esigenze ma viene trascinato in forme di divertimento imposte, create artificialmente, prefabbricate. Bambini che stanno insieme fisicamente ma che non socializzano affatto, tra loro non si creano rapporti interpersonali ma soltanto muri di isolamento e solitudine.
Osserva il Pitré “Questo fatto ha un grande significato per l’etnografia e porta un certo contributo nelle spiegazioni di alcuni fenomeni psicologici e sociali. Ci sono degli svaghi come quello dell’anello o del cerchio o della palla o della trottola o della moscacieca che si riscontrano sia fra i popoli dell’Europa che tra i negri dell’Africa, sia fra gli indigeni dell’America che nelle tribù selvagge dell’Oceania. Ciò dimostra che vari giochi hanno un fondo comune di tradizione, cioè uno l’ha imparato dall’altro, in epoche quando gli uomini delle primitive sedi dell’umanità si portarono nelle diverse contrade, modificandoli e adattandoli ai nuovi ambienti e alle nuove abitudini.” Il grande folclorista siciliano afferma che almeno un terzo di giochi conosciuti in Italia nell’Ottocento era patrimonio dei fanciulli e degli adulti di gran parte dell’Europa. In questo lavoro vengono riportati, in alcuni casi, nomi di giochi simili praticati in varie regioni italiane, non sempre, però, questi giochi sono perfettamente uguali, anzi spesso ci sono differenze nei regolamenti e nello stesso modo di giocare. Questo è il segno evidente della grande originalità e creatività che sta alla base dei giochi ma, che non esclude l’evidente collegamento tra le svariate espressioni. La maggior parte dei giochi di ieri si svolgevano all’aria aperta, erano passatempi semplici, salutari e più adatti alla vita di allora. Le case erano molto piccole e poco comode, mentre di spazi liberi se ne trovavano in abbondanza, la piazza diveniva un ottimo laboratorio. I momenti di tempo libero da dedicare al gioco erano veramente pochi ma, quando questo accadeva, giocavano tutti, grandi e piccini, e non mancavano gli spettatori che assistevano alle prove. I giochi erano basati sulla destrezza, sull’agilità, sulla velocità, sulla coordinazione ma principalmente sulla forza fisica. A volte diventavano violenti ed aggressivi perché, in parte, rispecchiavano i comportamenti sociali del tempo. I giochi, sono sempre figli del tempo e si adattano al contesto sociale nel quale si svolgono. Ieri non esisteva nessun disturbo dall’esterno, niente TV, niente computer, scarsissima produzione industriale di giocattoli con, in compenso, una solida presenza di rapporti interpersonali e di socializzazione. Era considerato importante lo stare insieme, anche i momenti di lavoro si trasformavano in occasione di socializzazione. La persona allora era al centro della società e il gioco era di tipo collettivo-creativo e ad alto contenuto sociale. I bambini di oggi non sanno più cosa voglia dire avere un cielo azzurro sulla testa, schiacciati dalla loro passività di soggetti cresciuti davanti alla TV, con gli occhi abituati ad incamerare sempre più immagini e a produrre sempre meno parole. Ieri il bambino non aveva bisogno dell’adulto, della guida, erano indipendenti ed autonomi nel gioco prima e nella vita, poi; oggi non sono abituati a scegliere, c’è sempre qualcuno che provvede ad indirizzarli verso qualcosa e quando non c’è l’adulto c’è bisogno del computer o di altro. L’oggetto giocattolo è il nulla e dietro di esso si aggrovigliano il vuoto delle relazioni umane e l’assenza della fantasia, della creatività e dell’inventiva; in questo modo il gioco, inteso come tempo della piena libertà infantile, viene spogliato di spazi ampi e differenziati e mutilato dei propri segni educativi quali il movimento, la comunicazione, la fantasia, l’avventura, la costruzione, la socializzazione. Il bambino, spesso, non sceglie in base alle sue esigenze ma viene trascinato in forme di divertimento imposte, create artificialmente, prefabbricate. Bambini che stanno insieme fisicamente ma che non socializzano affatto, tra loro non si creano rapporti interpersonali ma soltanto muri di isolamento e solitudine.